
Pubblicato inruminazioni
I bizzarri limiti di Outlook per Windows
Sono ormai molti anni che ho a che fare con l’informatica (come potreste agilmente verificare raspando indietro in…
Avventure di un astrofisico (ed altri) in mezzo ai bit


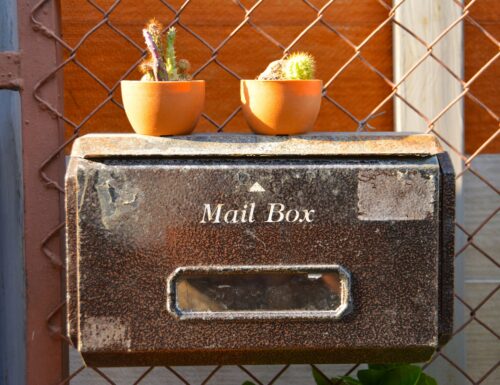

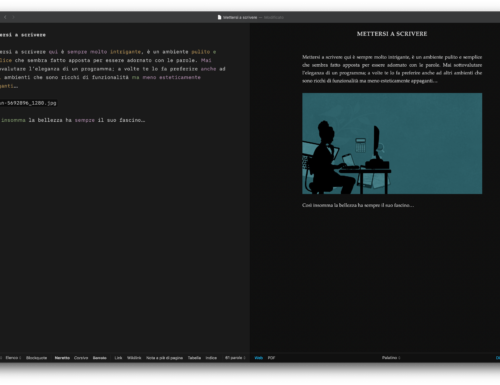
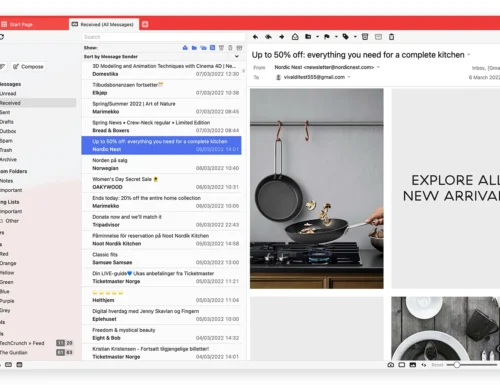

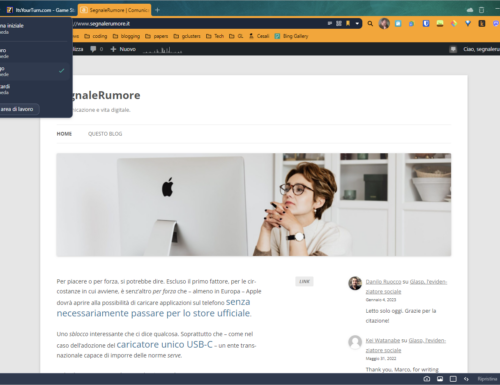


Tema Seamless René, sviluppato da Altervista
Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso - Privacy Policy - Personalizza tracciamento pubblicitario